
METODO E PSICOANALISI
Continuando a riflettere sul metodo psicoanalitico: estratti del seminario del 10 marzo 2022 del Dott. Cono Aldo Barnà
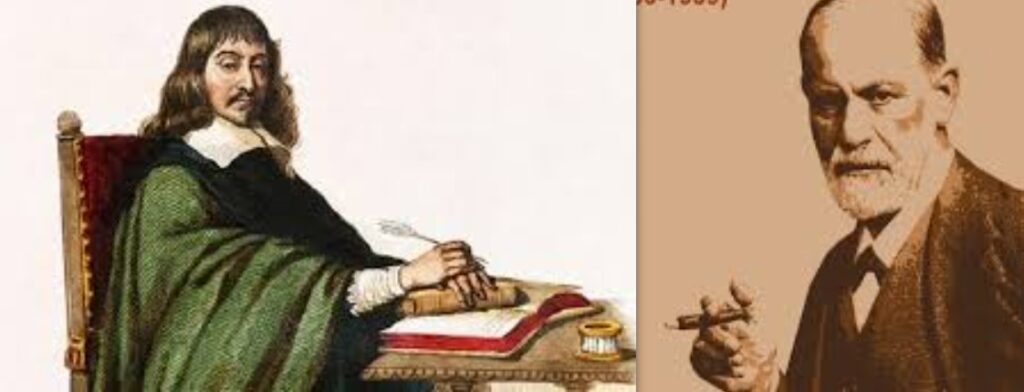
Introduzione
Riporto qui alcuni passaggi del seminario sul metodo psicoanalitico tenuto dal Dott. Cono Aldo Barna, psicoanalista con funzioni di Training della Società Psicoanalitica Italiana (SPI), alternati ad alcune mie riflessioni o commenti.
1. Metodo scientifico e metodo psicoanalitico
Nella prima parte del seminario viene proposto e rilevato come la tecnica psicoanalitica si sia negli anni riformulata allontanandosi apparentemente da una presunta scientificità. In particolare già da uno degli ultimi scritti di Freud (Costruzioni in analisi) veniva proposto che lo strumento principe dell’analista non erano più le interpretazioni ma le costruzioni.
“la stessa psicoanalisi, considerata al dunque una scienza sui generis, con una definizione che rimane, comunque problematica, conduce ad una serie di fraintendimenti e critiche che non rendono giustizia alla nostra disciplina.
Come uscire da tali fraintendimenti? Riteniamo che ciò sia possibile ristabilendo con un’ampiezza e una coerenza epistemica adeguata, che la psicoanalisi è un metodo.
Un metodo che si riferisce ad una complessa teoria in divenire, con un proprio assetto operativo e che sono rintracciabili e definiti in essa fattori terapeutici specifici della mentalizzazione, che esiste infine in una comprensione adattiva del soggetto del proprio “essere nel mondo”.
Già Freud in “Costruzioni nell’analisi” (1938) aveva esplicitato la funzione della “costruzione” che tende ad assumere progressivamente una netta supremazia rispetto all’interpretazione considerata come la via regia dell’intervento. Si verificava così uno spostamento del baricentro del processo analitico in quanto le costruzioni possono essere concepite come processi transizionali, infinitamente più ampi, profondi e complessi delle interpretazioni stesse. Queste ultime infatti, per le finalità epistemiche che assolvono, sono lo strumento operativo di una logica corrispondentista: una forma linguistica che spiega come stanno le cose. La costruzione di contro sostiene una concezione della conoscenza di tipo non realista; come propone Hoffman (1992) essa rappresenta una delle possibili realtà che l’analista costruisce insieme al paziente, all’interno di un’azione che seleziona e esclude altri possibili tipi di realtà (De Robertis, 2001).
Detto in altri termini nell’epistemologia psicoanalitica si fa spazio l’idea che gli enunciati dell’interpretazione al pari degli enunciati delle altre scienze, non pretendono di porsi come “spiegazioni” del mondo, ovvero della realtà del paziente, bensì come “costruzioni” (Ambrosiano, Gaburri, 1998).
Essendo quindi divenuto il metodo essenzialmente costruttivo, dialogico ed intersoggettivo, viene ad assumere, nella sua declinazione complessiva, una funzione ancora una volta cruciale, coniugandosi in un modo nuovo e significativo con lo Junktim freudiano: il vincolo, o comunque il legame, tra teoria, tecnica e clinica in quanto vertici della necessaria correlazione istituisce il dominio osservativo della psicoanalisi. Il metodo si configura quindi come l’insieme dei criteri che regolano la correlazione tra i fatti osservati o desunti nel nostro campo conoscitivo e le teorie che consentono di osservarli o di desumerli (Thanopulos, 2020).
Che tipo di metodo è la psicoanalisi?
Una volta riconosciuto che la particolarità epistemologica della psicoanalisi si è andata coniugando con le ridefinizioni dell’epistemologia moderna, possiamo ora chiederci che tipo di metodo è quello psicoanalitico ed in cosa consiste
“Secondo Imre Hermann e Otto Fenichel, che ne hanno trattato a lungo, quello della psicoanalisi sarebbe un vero e proprio metodo sperimentale, in quanto, per sistematizzare l’osservazione, esso si avvale di una situazione controllabile e riproducibile ben caratterizzata e distinguibile dalle altre. Il lavoro psicoanalitico si affida per l’appunto ad un articolato e complesso dispositivo che comprende l’insieme delle condizioni che ne permettono e ne facilitano l’attuazione, gli strumenti idonei a rendere possibile il cambiamento nel paziente, una raffinata tecnica di utilizzazione e modulazione delle prime e dei secondi all’interno dei presupposti teorici che ne giustificano e legittimano l’applicazione, con l’aggiunta che il processo psichico dispiegantesi nell’ambito della situazione analitica non sarebbe altresì, in nessun caso, separabile dalla persona dell’analista (Hermann, 1963, Fenichel, 1934, 1941).
….
Si declinano così capacità euristiche e pratiche significative e sistematiche, con regole originali nelle quali sono riconoscibili basi antiche della cultura della cura, della speculazione e dell’attribuzione di significato all’esistenza umana e alla condotta individuale e collettiva.
Esse sono la dotazione del metodo psicoanalitico. Metodo che si è arricchito, attraverso gli aggiornamenti della teoria e della tecnica e tramite l’acquisizione di contributi provenienti dalla ricerca di discipline affini, ed ha così potuto rendere più esaustivi i modelli esplicativi del funzionamento mentale e della relazione terapeutica, senza però sovvertire i suoi elementi fondanti: libera associazione, scomposizione, personalità o persona dell’analista, come recentemente riformulati (Riolo, 2018).
…
Individuare ed interpretare tali elementi può “guarire” al contempo l’analista e la stessa psicoanalisi dalla idealizzazione e dal tormento epistemologico.
È utile quindi ribadire, per quanto attiene a quest’ultima questione, come si vada progressivamente delineando un’epistemologia solidale con una concezione non corrispondentista, in base alla quale il sapere non è dato, ma interpretato e costruito.
…
Con il tempo è stata la stessa epistemologia a demitizzare l’idea di una scienza pura, indipendente dal tempo, dalla storia e dalla complessità. Grazie quindi ad una maggiore e più congrua flessibilità, oggi assistiamo ad una relativizzazione delle demarcazioni assolute tra scienze dure e scienze umane. Secondo questa nuova prospettiva non esistono principi universali di razionalità che permettono di classificare e giudicare vera in assoluto e una volta per tutte una proposizione scientifica. La realtà non è preconfezionata nella conoscenza, non è oggettivamente data, ma è funzione dell’osservatore e del contesto, ossia dipende da come viene concepito il mondo e non da come il mondo è.
Sono quindi le proposte implicite ed esplicite del metodo che configurano la competenza specifica dell’analista: la motivazione, l’equilibrio, l’atteggiamento, il tratto, l’ascolto, l’incubazione, l’identificazione, l’empatia, il timing, il silenzio, il turno, la prossimità affettiva e di linguaggio, la ricchezza interiorizzata delle mappe teoriche e di quelle cliniche esperienziali, la coerenza e la costanza di tante ore di volo, la certezza e la forza del contenimento acquisito nella formazione e nell’esercizio clinico, la sincerità e la profondità della propria disposizione autoanalitica, l’elasticità delle difese e l’utile dislocazione osservativa nel proprio assetto operativo.
La doppia asimmetria funzionale: un garante del metodo
Ad ulteriore specificazione si viene ad individuare nella situazione analitica ciò che garantisce il buon funzionamento di un’analisi. Infatti stabilire che il metodo non è più basato sull’interpretare una verità vera da parte di un’analista in possesso di un metodo di conoscenza superiore, comporta il rischio di una confusione di ruoli dove entrambi i partecipanti, analista e paziente possono contribuire in egual misura a costruire e ricostruire. Diventa allora utile esplicitare il ruolo di garante che ha l’asimmetria nel rapporto tra analista e paziente
In merito all’assetto operativo “riporterei sinteticamente alcune riflessioni a riguardo dell’“asimmetria funzionale” del dispositivo analitico
Partirei dalla formulazione che il lavoro analitico si svolge procedendo dalla concezione di “oggetto” della psicoanalisi che si è costruita dentro l’analista e dalla sua coniugazione nell’incontro con il paziente, tramite i contributi di quest’ultimo (Green 1974, Barnà 1990).
Intendendo cioè che anche da parte del paziente sussista un “oggetto” della psicoanalisi, magari meno evoluto e formalizzato, ma che, nel lavoro analitico, esso è reciproco e interagente con la proposta dell’analista.
Quest’ultima, e il portato del paziente, si integrano, a mio avviso, nelle vicende del transfert e nello stile di ogni analisi. Concordo infatti con quanti sottolineano l’aspetto “interattivo” della relazione analitica e quello di “nuova possibilità” attribuita al transfert, inteso non tanto o non soltanto come pura ripetizione di emozioni precedentemente vissute, ma come un prodotto della stessa situazione analitica, essendo quest’ultima una formidabile fabbrica di fantasmi (Macalpine 1950, Laplanche 1986, 1987).
L’andamento della relazione, derivante quindi dall’incontro dinamico del mondo interno dei due partecipanti può costituirsi però nella sua modalità specifica grazie alla proposta implicita inerente la struttura complessiva del rapporto analitico, ben oltre quindi il ruolo esplicito del setting e della tecnica adottati.
L’alone semantico, implicito nella struttura del rapporto, orienta l’andamento regressivo del transfert e la produzione onirica, associativa e metaforica, che costituiranno la narrativa e il testo dell’analisi; ciò a partire dalle inferenze della coppia analitica sul vissuto del paziente in relazione alla dipendenza, così come essa si esplicita nel transfert (Flem 1987, Gallese 2006).
Tutti gli autori insistono ormai fortemente su questa accezione costruttiva del lavoro analitico: ciò che si svolgerebbe, essendo costruito dalle sue stesse coordinate non riprodurrebbe alcuna esteriorità. Cosicché il lavoro di elaborazione non mira a ritrovare una storia reale, né a ricostruire degli eventi passati, ma a costruire una nuova storia potenzialmente capace di dialettizzare ed integrare gli aspetti dissociati dai fattori traumatici della crescita del soggetto.
…
La situazione analitica contempla un uso specializzato della regressione in quanto esito intermedio del setting prodotto dalla doppia asimmmetria funzionale che esso contempla (Macalpine 1950, Barnà 1990).
La prima asimmetria essendo già presente nelle motivazioni per le quali i due membri si incontrano: il paziente provenendo dal sottogruppo di chi ha bisogno di cure o di chi non sa (Edipo), l’analista dal sottogruppo specializzato di chi dispensa cure o di chi conosce (Tiresia).
Essa è quindi, in parte, precostituita, rispetto allo stesso incontro, essendo sostenuta da elementi precedenti, esistenti nella cultura del gruppo e nei modelli della sofferenza, della cura, dell’allevamento e della formazione.
Come tale, comunque, l’asimmetria suddetta è già un potente veicolo di regressione e troverà accoglimento, rinforzo ed elaborazione nella successiva configurazione asimmetrica del rapporto analitico. Essa si coniuga infatti, nel setting, con una seconda “asimmetria funzionale”, anche questa destinata ad essere elaborata nel corso dell’analisi.
Mi riferisco in particolare alla disposizione poltrona-divano e all’assetto psicosomatico, simbolico e semantico secondari a questa collocazione corporea, spaziale dei membri del rapporto.
Una collocazione che non è stata, a mio avviso, approfondita in tutte le sue implicazioni. Certamente essa va al di là dell’intenzione di Freud di evitare di essere guardato e dà luogo, oltre che a comprensibili effetti di modificazione dell’assetto di controllo mentale e relazionale abituale, ad una conferma e ad una specificazione produttiva della asimmetria precedente (culturale o ideologica).
La disposizione dei corpi nello spazio analitico configura una relazione di “allettamento” tipica del rapporto medico-paziente, ma non solo, e quindi con un alone semantico molto ampio (Flem 1986). Questo alone suggerisce l’andamento associativo significante tendente ad esplicitare una serie di contenuti polisemici complessi dell’allettamento e della dipendenza. Quelli ad esempio transferali di carattere erotico, di contenitore-contenuto, di attività-passività, così come quelli di infante-adulto o più specificamente madre-bambino.
…
Le altre componenti del setting, e del metodo, si pongono a confermare l’asimmetria e a contenere la regressione e la produzione affettivo/verbale in regime di regressione, separando la relazione analitica dalla realtà esterna e proteggendola da essa. La costanza di luogo, quella oraria e di atteggiamento dell’analista, la sua disposizione empatica e recettiva, l’astinenza e la neutralità, assicurano le condizioni standard, prevedibili e affidabili, perché la regressione possa avvenire, esser riconosciuta e progressivamente elaborata. Condizioni che, agendo in primis sullo psiche-soma, eserciterebbero un’azione terapeutica diretta sui funzionamenti somatici e psicologici di base (Bonfiglio 2020).
La metafora del monitor
Per esplicitare l’assetto operativo dell’analista in seduta, l’autore propone la metafora del “monitor”. È un modello usato per raffigurare l’attitudine mentale dell’analista in seduta
Comunque, dell’assetto affettivo e/o operativo di cui parlo, fa parte una funzione mentale, incidentale e/o accessoria che assume la forma di spontaneo, irriflessivo, “monitor mentale” dei parametri utili alla lettura – in continuo- delle condizioni e dell’andamento della relazione analitica.
Si tratta di una funzione, attivata nell’analista da una parziale dissociazione mentale rispetto all’impegno affettivo reciproco che processa – appunto in continuo – nella mente dell’analista, gli elementi significativi dell’andamento dello scambio all’interno della seduta e che segnala prevalenze, pericoli, urgenze ed emergenze.
Si tratta quindi di una disposizione particolare nell’assetto dell’analista che deve, da un lato affidarsi al gioco delle associazioni e della fantasia, abbandonandosi al suo stesso inconscio, dall’altro, il materiale prodotto da sé stesso e dal suo paziente ad un esame osservativo critico, in modo da essere guidato da entrambi i vertici (Ferenczi 1919)
Gli elementi risultanti dalla implicita continua monitorizzazione del contrasto, sono, di solito, affidati ad una specie di aggiustamento automatico dell’assetto mentale e relazionale dell’analista il quale si dispone in modo da superare le resistenze e facilitare l’ulteriore sviluppo del contesto. Essi possono però condurre, in caso di andamento problematico, ad interventi sempre più espilciti da parte dell’analista, fino alle operazioni di salvaguardia dei parametri formali della relazione analitica: il contratto, il setting, la ricontestualizzazione, l’azione diretta cosciente.
…
I tracciati della monitorizzazione, che in seduta hanno causato l’aggiustamento empatico e operativo dell’analista, forniscono quindi, nel tempo extra-analitico, gli elementi di riflessione strategica dell’andamento di quell’analisi e l’elaborazione necessaria all’analista per tornare in seduta “al meglio” capace cioè degli ulteriori aggiustamenti necessari a ricevere di nuovo il paziente in una condizione quanto più prossima possibile al suo standard.
Conclusioni
Per concludere vengono rintracciati i molti aspetti problematici aperti dalla riflessione psicoanalitica nel suo operare con i pazienti, in particolare in relazione alla validità degli interventi verbali rispetto ad una realtà (psichica) non verbale.
“Riconsiderando quindi il nostro metodo, avvertiti tra l’altro della ricchezza e della complessità dei contributi che suggeriscono l’aggiornamento e la trasformazione della nostra concezione dell’inconscio, vorremmo esplicitare ulteriormente le problematiche che proprio a partire da tale nuova concezione ricadono sul trattamento analitico e sull’assetto clinico (Barnà 20017, 2010). Una prima significativa, conseguenza si esprime come dubbio relativo al fatto che gli interventi verbali debbano intendersi come il veicolo terapeutico ottimale (Bucci, 2002). Con tale riflessione si articola il suggerimento di usare il linguaggio non tanto per trasmettere significati e chiarire situazioni, ma anche per evocare stati della mente, per generare e connettere aree di esperienza” (Mitchell, 2000). Ciò comporta in definitiva “un’enfasi sull’attivazione dell’esperienza affettiva, piuttosto che sull’inibizione dei desideri o della pulsione” (Bucci 2002). Lo scambio verbale tra analista e paziente vanno quindi intesi soprattutto come “traduzione intersemiotica” dagli affetti al linguaggio e la stessa interpretazione come fattore terapeutico specifico “per quella che essa attiva piuttosto che per ciò che svela” (Martini 2005, 2009). Occorre soprattutto concedere un’attenzione costante ai livelli più informi dell’inconscio, quelli che non hanno avuto ancora accesso alle dimensione rappresentazionale, ed essere solleciti nei confronti dell’emergere della “pensabilità” (Tagliacozzo, 1982).
Un modello dialettico della psicoanalisi implicherebbe quindi che se ne riconosca lo specifico nella possibilità di costituire connessioni tra il rappresentabile e l’irrappresentabile, tra il conscio e l’inconscio, tra l’intrapsichico e l’interpersonale, tra l’interazione e il transfert (Martini, 2009). È così che in un’attenta riformulazione del metodo, è possibile affermare che “l’oggetto della psicoanalisi non è il conscio, né l’inconscio bensì il transito di elementi selezionati tra l’uno e l’altro” (Riolo, 2002). Il tutto in un contesto particolare come quello analitico capace di realizzare la circostanza singolare per la quale la relazione con un’altra persona diviene il canale di accesso alle dimensioni mentali più informi e arcaiche e al loro potenziale sviluppo. In una prospettiva quindi in cui il fattore terapeutico ultimo consisterebbe nel costruire e nell’accrescere lo spazio per la simbolizzazione. Potendo questo avvenire attraverso l’interpretazione, il silenzio o l’ambiente contenitore, in definitiva soprattutto con la capacità di mettersi in gioco in quanto persone allenate e fiduciose nella sintonia riparativa più profonda.







